Articolo di Giulia Fortunati
Lo “sharing” è oggi più che mai una delle attività più naturalizzate e radicalizzate nelle piattaforme social, soprattutto quando si tratta della sua specifica declinazione in “life sharing”. Esso altro non è che una nuova modalità di presentarsi e rappresentarsi online tipica dei processi di socializzazione, che finisce per costituire spesso una fase preparatoria e antecedente all’accadimento delle tradizionali relazioni della vita quotidiana.
Il “self sharing”: le origini
Il primo risultato che appare sulla pagina di ricerca dopo aver googlato “life sharing” è il risultato più lampante, concreto e letterale di cosa si può intendere con “condivisione della vita”. Ciò che appare è quello che resta di un esperimento fatto anni fa da una coppia di artisti, Eva e Franco Mattes, che decisero di fare della loro vita privata una vera e propria opera d’arte, rendendo pubblici per ben tre anni (2000-2003) ogni genere di informazione contenuta nel loro personal computer. Come espresso dai due stessi autori, in un momento in cui i social network ancora non esistevano – o comunque non si erano affermati - l’obiettivo era il condividere e il rendere disponibile ogni contenuto privato cosicché potesse esser letto, registrato o copiato. Tutto questo accompagnato dall’affermazione, sicuramente provocatoria, “privacy is stupid”.
Pensare alla propria privacy, o pensare di riuscire a mantenerla, è davvero “stupido” o insensato? Forse lo è, solo se continuiamo a preservare con persistenza il concetto di riservatezza ancorato a una realtà prettamente ed esclusivamente offline. È una visione di organizzazione e di relazionalità umane che oramai è conclusa, o almeno, che è stata integrata con nuove dimensioni. Basta pensare a un social media come Instagram, che si afferma proprio per permettere agli utenti, tramite la fotocamera presente sullo smartphone, di fotografare, pubblicare e condividere nel giro di pochi istanti micro-esperienze della vita quotidiana, attimi, eventi personalmente e privatamente importanti. Esattamente come permette di farlo anche Snapchat, o lo stesso Facebook, che da qualche anno offre anche la possibilità di far diventare i profili personali dei veri e propri diari interattivi presentati da Mark Zuckerberg come “storia della propria vita” (Vittadini, 2018).
“Life sharing”. Condivisione della propria vita. Condivisione della propria vita personale come nuova forma di storytelling, di supporto e di sviluppo della rete sociale. Scegliere di condividere informazioni – sotto forma di testi, immagini, video – riguardanti il proprio percorso di vita intimo non solo con “altri differenti da me”, ma con utenti sconosciuti, all’interno di reti sociali multiple e non direttamente visibili e conoscibili.
Quello che oggi avviene tramite i social media non sembra molto diverso dal gesto fatto da Eva e Franco Mattes quasi venti anni fa: creare e condividere contenuti basati interamente sulla vita personale, dal postare foto dei nostri viaggi, al far vedere quante bevute vengono consumate il sabato sera, al mostrare il pranzo di Natale, fino ad arrivare a condividere foto di un’ecografia. Ma dietro tutto questo, ci può essere davvero una discriminazione così forte da impedire ogni atto di “self sharing” o da determinare negativamente la futura considerazione della persona? Se queste piattaforme social sono pensate per far proliferare la rete dei legami sociali, per quale motivo non si dovrebbe – sulla base di cosa si vuole condividere e con chi - mostrare attimi della propria vita? Come ha scritto E. Goffman (1959)
“Le notizie riguardanti l’individuo aiutano a definire una situazione,
permettendo agli altri di sapere in anticipo che cosa egli si aspetti
da loro e che cosa essi, a loro volta, possono aspettarsi da lui:
tali informazioni indicheranno come meglio agire per ottenere una sua
determinata reazione” (p.11)
Quello che un individuo – in questo caso un utente – rilascia agli altri risulta quindi essere una condizione basilare irrinunciabile per poter effettivamente parlare di relazioni interpersonali. Se nella dimensione della realtà che oggi chiamiamo “offline” alcuni aspetti o espressioni possono trasalire inconsapevolmente e non volutamente dall’individuo, finendo così per essere gli elementi su cui gli altri verificheranno l’attendibilità e la veridicità di quanto detto al soggetto (Goffman, 1959), nell’altra dimensione, quella “online”, questo rischio va a diminuire, dal momento in cui il singolo utente, usufruendo della non immediatezza fisica presente invece nella comunicazione “face to face”, può gestire meglio le proprie presentazioni, reazioni e risposte. Senza che questo ovviamente debba necessariamente cadere in una falsa rappresentazione del sé.
Attività rilevanti da considerare nel più generale processo di “life sharing” da porre sotto il faro dell’attenzione – sono due: quella conosciuta come “self- disclosure” e il “personal branding”.
SELF-DISCLOSURE
La natura del “self-disclosure”
Il “self-disclosure” viene inteso come un qualsiasi messaggio riguardante il proprio sé che un individuo comunica agli altri (Cozby 1973; Wheeless 1978, citati da Yang e Tan, 2012). Informazioni che possono variare sia in ampiezza, a seconda dei campi trattati (famiglia, lavoro, orientamento politico ecc), sia in profondità, a seconda del grado di superficialità del contenuto comunicato (Utz, 2015). Ma esattamente cosa spinge le persone a rivelarsi? È dimostrato che ci piacciono di più le persone che si disvelano, ci apriamo di più a chi ci piace, e quando divulghiamo, preferiamo farlo con chi a sua volta ha piacere nel divulgare per primo (Collins & Miller, 1994, citati da Utz, 2015). Quando una persona si presenta in una data situazione, indirettamente o direttamente si sta mostrando con una certa identità e con un certo modo di essere, elementi su cui gli altri si baseranno per capire come trattare il “nuovo arrivato” moralmente e socialmente (Goffman, 1959). Dal momento in cui questo vale anche negli ambienti social, il vantaggio che si trae dal condividere aspetti del sé in modo volontario, decidendo quindi personalmente cosa comunicare e a chi, pare evidente.
Secondo la teoria di Derlega and Grzelak’s (1979, citata da Yang e Tan, 2012) cinque sono le motivazioni, e quindi i vantaggi, che spingono le persone a autorivelarsi: convalida sociale, autoespressione, sviluppo relazionale, chiarimento dell'identità e controllo sociale. La convalida sociale permette di veder approvato dagli altri il proprio sé sociale, l’autoespressione porta allo sfogo di problemi personali e di emozioni negative, lo sviluppo relazionale permette di consolidare i rapporti con altri individui, il chiarimento identitario fa meglio definire il soggetto a sé e agli altri, mentre infine il controllo sociale dà la possibilità all’individuo di controllare le reazioni sociali degli altri e le informazioni che vengono sviluppate su di sé. Questo aperto prolungamento del sé, utile a mostrarsi sia verso ambiti che nella vita offline non si sono disvelati sia verso circoli nuovi di persone, sembrerebbe dipendere anche dagli indicatori ambientali che provengono dall’esterno (Omarzu, 2000, citato da Yang & Tan, 2012): come un ambiente romantico spinge l’individuo a sviluppare meglio una tipo di relazione rispetto a un ambiente di ufficio, così gli ambienti social, con l’apertura che offrono su reti sociali nuove e potenzialmente avvicinabili spingono e aiutano l’utente a condividere frammenti del proprio sé.
I vantaggi dell’esporsi via social
La condivisione del proprio sé permette all’individuo di raggiungere un senso di fiducia e l’obiettivo di essere compreso dagli altri (Altman and Taylor 1973; Derlega and Grzelak 1979, citati in Yang & Tan, 2012). I social media rappresentano in questo un ambiente, affermatosi relativamente di recente, che incrementa di fatto la possibilità di avvicinarsi a reti sociali nuove, viste come un prerequisito necessario per accumulare quelle risorse personali concepite come il “capitale sociale” (Coleman, 1998, citato in Yang & Tan, 2012).
Partendo dalla constatazione data dal cosiddetto “paradosso del controllo” (Vittadini, 2018) dove è l’individuo a decidere, in caso di presenza di un pubblico non ben definito, se esercitare o meno una maggiore selettività sui contenuti da pubblicare, quando un utente decide di auto-rivelarsi, condividendo foto, video, aggiornamenti di stato, post in cui dà immagine di sé, sta indirettamente chiedendo interazione (Yang & Tan, 2012).
Se molti affermano i rischi legati alla divulgazione del sé “senza freni” o “senza filtri”, la prospettiva da assumere qui è vedere come gli utenti possano trarre beneficio non solo scoprendo nuove realtà, condividendo situazioni o esperienze – anche traumatiche o dolorose – con un pubblico molto più vasto di quello offline, ma anche dall’ auto-riconoscersi o dall’auto-conoscersi tramite quest’opera di rivelazione del sé. L’utente impara che ci sono situazioni simili alla propria, che il suo punto di vista non è il solo e non è sempre quello reale o corretto, che c’è chi è pronto a sferrare attacchi ingiustificati solo per il piacere di farlo, a sottoporsi a una maggiore visibilità, a vedersi e a vedere gli altri sotto altre luci. Impara e allo stesso tempo ne trae vantaggio.
L’espressione “write oneself into being” (scriversi per esistere) non è casuale (boyd, Heer, 2006, Sunden, 2003, citati da Vittadini, 2018).
Offline e online a confronto
Gli individui/utenti sono portati a pubblicare e condividere contenuti personali all’interno di una rete sociale online perché la creazione del profilo personale con l’immissione di informazioni private è il requisito dell’esistenza stessa dei social media, in cui i profili personali vengono visti come propri artefatti performativi che costituiscono vere e proprie ancore conversazionali (boyd, Heer, 2006, citati da Vittadini, 2018). “Quando un individuo viene a trovarsi alla presenza di altri, vorrà essere al corrente dei fatti della situazione” scrive Goffman (1959, p. 285).
Nel mondo offline questi fatti non sono visibili e conoscibili nell’immediato, ma salgono in superficie man mano che la conoscenza prosegue e si fa più profonda. Si pensi invece a un profilo social: a un utente basta scorrerlo, di contenuto in contenuto, osservando i vari post, guardando le foto degli album, leggendo i commenti in risposta ad altri, per farsi un’idea su un utente che potrà andare a valutare poi di persona. Senza contare poi che, in un ambiente social, la rivelazione del sé può essere più e meglio controllata rispetto alla realtà offline: i “gesti non intenzionali” che rischiano di comunicare impressioni sbagliate o distorte sul proprio sé (Goffman, 1959), nei social possono essere evitati con più facilità. Se nella comunicazione “face to face” il rossore sul viso, un’espressione spontanea inadatta, il sudore, il tremolio, una risposta immediata, possono creare problemi nell’interazione, il mondo social fa da mediatore e da filtro se vogliamo a queste insicurezze e a questi rischi, dando così l’opportunità di presentarsi come desiderato.
L’attacco mosso alle piattaforme social sul tema condivisione pare dunque ingiustificato: l’apparizione online di un’identità che non corrisponde a quella reale è un effetto collaterale da non addossare alle potenzialità di condivisione del sé dei social. La colpa in questo caso sta nelle persone.
Lifesharer.com
Può esistere qualcosa di più personale di un ricordo di un pezzo di vita passato con una persona amata ma purtroppo venuta a mancare? “Lifesharer. The Story of a Lifetime” permette di condividere tali ricordi. Si tratta di un sito online dove gli utenti registrati hanno la possibilità di condividere foto, video, contenuti testuali esclusivamente per il piacere e il sollievo di esternare e di “render vivo” il pensiero costante rivolto ad una persona amata scomparsa. “Lifesharer” dà la possibilità di ricercare, tramite l’immissione del nome, di un periodo temporale e di una zona geografica, storie di utenti provenienti da ogni angolo del mondo, per rendere ancor più probabile riuscire a confrontarsi con esperienze di vita simili con cui paragonare o confrontare la propria.
La possibilità che offre una piattaforma come “Lifesharer” è quella di veder raggruppate tutte insieme all’interno dello stesso spazio storie di vita che hanno tutte lo stesso sfondo: il dolore e la volontà di ricordare l’altro con amore.
Se nella realtà offline le occasioni per confrontarsi su questo genere di esperienze sono limitate, i “Lifeshares” attivano una forma di condivisione strettamente personale, basata sull’empatia e sulla capacità di sorreggere l’altro, condividendo ad esempio una storia di un altro, aggiungendovi un epitaffio personale o lasciando all’utente una condoglianza, un messaggio di impressione o un ricordo da parte di chi conosceva la persona scomparsa.
Un’attività di “sharing” strettamente personale, che permette però di trovare ed offrire conforto, supporto e motivazione, perché la condivisione è spesso connotata da valori positivi, tra cui il prendersi cura degli altri. “Sharing is caring” (Jhon, 2013, citato da Vittadini, 2018).
Silvia Fascians
La visione dello “sharing is caring” (Jhon, 2013, citato da Vittadini, 2018) può forse essere intesa anche come una prima forma di cura per se stessi, poi reindirizzata agli utenti che compongono le varie reti sociali. È quello che può aver fatto una giovane ragazza, Silvia Fasciano (sui social presentata e conosciuta come Silvia Fascians), che ha deciso di raccontare tramite Youtube e Instagram principalmente, la sua esperienza riguardo l’anoressia, step by step.
Su Youtube Silvia si presenta come una “semplice ragazza” con un preciso obiettivo: ispirare gli altri nel seguire uno stile di vita sano, senza smettere mai di amare se stessi. I suoi video spaziano dal “cosa mi ha spinta a voler guarire”, al proporre idee di pasti “fit” e ben bilanciati, al voler descrivere precisamente che cosa è e che cosa comporta davvero la malattia dell’anoressia, al mostrare esercizi di allenamento da fare in casa o in palestra.
Fino ad arrivare a oggi, dove Silvia condivide, soprattutto su Instagram, pezzi della propria vita quotidiana, la laurea, il come passa le giornate, il chiedere consigli (spesso tramite IG stories) ai suoi follower, i suoi momenti di fragilità. Perché questo? Perché Silvia nel corso degli anni è riuscita a costruirsi su Youtube una community di quasi 55.000 iscritti al suo canale, e conta su Instagram più di 140.000 follower, che l’hanno portata ad essere oggi una delle più importanti “fitness influencer” in Italia e persino “ambassador” di Adidas.
Sebbene non tutte le realtà raccontate tramite social si tramutino poi in storie molto seguite e condivise, il percorso di crescita di Silvia online è stato reso possibile dall’incontro tra la sua spontaneità e la voglia di aiutare con i giusti mezzi per farlo. La condivisione gioca un ruolo fondamentale nel diffondere una storia raccontata, che così può diventare, se si vuole, una vera attività di “personal branding”. Le interazioni rilasciabili sui social media (like, commenti, ecc.) non solo possono aiutare a capire come orientare e gestire i contenuti da offrire al proprio pubblico, ma permettono un’interazione sempre più diretta (basta pensare alle IG stories su cui è possibile porre domande per ricevere risposte dagli utenti stessi o grazie alle quali possono essere fatti sondaggi) là dove, nella realtà offline, sarebbe impossibile gestire una comunicazione “ one to one” coinvolgente per migliaia di persone sempre riuscendo a trasmettere i giusti messaggi, nel modo corretto e con la giusta intenzionalità.
Instagram Story di Silvia Fascians, Instagram
Se online le persone sono spesso tentate a cercare da sole informazioni per poter compiere un’autodiagnosi e trovare anche la “giusta” terapia, il racconto personale di una ragazza poco più che ventenne tramite piattaforme social che si prestano come specchi del quotidiano più banale e che rispecchia la realtà di numerose altre persone, può essere ancora di maggior aiuto.
A chi critica a Silvia un’esposizione eccessiva, la ragazza risponde semplicemente dicendo che quello che suoi follower possono vedere su Instagram è la sua vita, a 360°, tra studio, lavoro e fitness, solo resa più fruibile e condivisibile per gli altri.
PERSONAL BRANDING
L’altro aspetto adesso da analizzare è quello che viene generalmente definito “personal branding”. Innanzitutto, che cos’è? È il processo per cui le persone, con le loro qualità e carriere, sono presentate come veri e propri brands per creare un bene e un valore senza gli ingenti costi finanziari che di solito vengono richiesti nella realtà offline per promuovere l’“awareness” del marchio e una sua devozione (Karaduman, 2013). Fare “personal branding” significa riuscire a impostare una strategia comunicativa che riesca a mostrare agli altri i propri punti forza, le proprie capacità, ciò che si sa fare meglio e ciò che distingue il singolo in questione da tutti gli altri concorrenti. E in questo, i social media possono essere visti come il doping per il “personal branding” (Centenaro & Sorchiotti, 2013).
L’inizio del “personal branding”
Il mondo degli affari sta di fatto iniziando a riconoscere l'importanza di esercitare un controllo sui marchi personali tramite l’uso delle piattaforme social (Labreque, Markos & Milne, 2010), tanto che, secondo un’indagine condotta da Gidp/Hrda, il 71% delle aziende italiane va a controllare i profili social dei candidati per trarre informazioni su di loro, soprattutto tramite Facebook e Google (Centenaro & Sorchiotti, 2013). Tom Peters, colse fin dal 1997 l’importanza del farsi brand e promuoversi, in un articolo da lui scritto intitolato “The Brand Called You”, “la marca chiamata te” (Peters, 1997).
Dal momento in cui il Web dà la possibilità a tutti di esplicitarsi, di spiegarsi e di avere un proprio sito, la differenza la fa l’azione di branding. I siti su cui gli utenti tornano sono i siti di cui si fidano di più, e questi siti non solo altro che lo strumento di presentazione di se stessi come brand. Qualsiasi individuo può essere un marchio tanto quanto la Nike o la Coca-Cola: il segreto sta nel porsi la stessa domanda che i brand manager di questi grandi marchi si pongono: “che cosa mi rende unico e di valore?”. Deve essere qualcosa di cui l’utente si può prendere spudoratamente il merito, senza dimenticare però che il valore del proprio marchio non deriva tanto dal proprietario, quanto invece da ciò che viene detto dagli altri, dalla propria rete di contatti, dagli amici, dai clienti che valuteranno la qualità del brand presentato (Peters, 1997).
In una ricerca svolta su un campione costituito da manager di aziende e da clienti e non clienti già seguaci di tali rappresentanti sui social media e in cui l’attività di “personal branding” viene considerata come variabile dipendente mentre l’esistenza dei social media e il coinvolgimento attivo come variabili indipendenti (Karaduman, 2013), è stato dimostrato come la presenza sui social media e una partecipazione attiva su di essi sono estremamente favorevoli per coloro che sono già clienti dei vari brands. Attraverso una gestione ben progettata del brand e con un alto livello di coinvolgimento, i manager aziendali traggono beneficio per il valore dell’azienda, perché i clienti si mostrano intenzionati a essere impegnati e coinvolti nella rappresentazione del brand proposto.
I segreti del crearsi come brand online
Ma come i social media possono offrire vantaggi e risvolti positivi alla pratica del “personal branding”? Importante premessa da fare è che il “personal branding” non è una semplice attività di auto-promozione, che tutti possono sviluppare solo per l’apertura a molteplici audience offerta dai social media. La visibilità va guadagnata, perché permette di far entrare i potenziali clienti dalla porta. Una volta ottenuta, serve la competenza per farli restare. Questa è la chiave del successo, non c’è nessuna scorciatoia (Centenaro & Sorchiotti, 2013). Grazie alla Rete e soprattutto alle piattaforme social, è possibile diventare media di se stessi, non vi è alcun attaccamento o dipendenza da parte di un datore di lavoro, ma un individuo sta vendendo se stesso piuttosto che un marchio legato a un'azienda (Shepherd, 2005, citato da Labrecque, Markos & Milne, 2010). Questo però non significa riempire le proprie pagine personali o i propri profili con riferimenti ridondanti ai propri successi, ai premi vinti, o con foto con persone famose ma, anzi, si tratta di sfruttare la maggior socializzazione che i social media offrono per potenziare la propria rete di contatti che forma il capitale sociale (Centenaro & Sorchiotti, 2013).
“Del resto, come già abbiamo visto, la questione è: i futuri clienti
si baseranno più sul tuo curriculum vitae o sull’opinione di coloro
che hanno già usufruito dei tuoi servizi e possono garantire
sulla tua reputazione?” (Centenaro & Sorchiotti, 2013, p. 84).
Basta anche solo vedere, prendendo ancora ad esempio il mondo del fitness, quanti personal coach decidano di pubblicare (omettendo nome e cognome) foto dei propri clienti dei progressivi miglioramenti fisici fatti nel tempo spiegando anche la metodologia adottata, mostrandosi in questo modo direttamente a nuovi potenziali clienti competenti, affidabili e sicuri.
Instagram story e post, Instagram
I social media sono oggi un ottimo strumento per fare ricerche di marketing, per monitorare il proprio marchio e per osservare costantemente l’evoluzione dei giudizi e delle opinioni delle persone (Centenaro & Sorchiotti, 2013). Ad esempio un individuo può mostrare su Twitter di aver risposto a domande altrui, dimostrando così di aver aiutato gli altri grazie alle capacità e conoscenze personali, così come può ricevere e palesare su LinkedIn le varie raccomandazioni da parte dei clienti che hanno da lui ricevuto un aiuto.
In poche parole, i social media permettono di tornare a una delle più tradizionali forme di comunicazioni efficienti, potenziandola notevolmente: il passaparola (Reynolds, 2011). La relazione orizzontale che si va a creare tra gli utenti sui social media favorisce una continua innovazione e una sempre più crescente stimolazione. Due persone con competenze complementari ma fisicamente lontane hanno l’opportunità di entrare in contatto, di confrontarsi, di creare eventuali progetti e accrescerel’“awareness” l’uno dell’altro (Prunesti & Perciavalle, 2013).
Il caso di Vincenzo Falcone
Vincenzo Falcone (conosciuto come Vincenzo Falcone Delicious) è un normalissimo ragazzo proprietario di una catena di ristoranti in provincia di Salerno (una pizzeria, una baguetteria e un ristorante sushi) di poco più di trent’anni, ma con un seguito di 186.000 follower su Instagram.
Come è riuscito a crearsi una community così vasta se la sua attività è così comune e diffusa? La sua peculiarità e punto di forza è stata quella di aver fatto leva - grazie ai social e alle potenzialità di passaparola virtuale correlate - sulla propria esperienza lavorativa e di vita e di aver fatto così scoprire, grazie alla condivisione continua della propria arte culinaria mezza italiana mezza americana, la sua particolare attività.
profilo Instagram di Vincenzo
Falcone, Instagram
In un ambito pieno di concorrenze e nuovi arrivi, la circolarità dei contenuti, la possibilità di entrare in contatto diretto con nuovi potenziali clienti e mostrando loro (ad esempio tramite IG Stories) come un dolce viene realizzato, come il pizzaiolo si destreggia in cucina o come i clienti gustano con piacere i loro piatti, sono tutte forme indirette di esaltazione delle proprie capacità. Sono attività che permettono di creare più familiarità e vicinanza, ma soprattutto permettono di distinguersi e di proporsi come un “brand” del tutto autentico.
In conclusione, che cosa ha di diverso allora il “self sharing” online da quello offline?
La possibilità di mettere in scena – come direbbe Goffman – il proprio sé di fronte a un pubblico più vasto. I filtri che possono essere applicati nel mondo social per ottimizzare una rappresentazione personale sono presenti anche nella realtà offline: aspettative, ruoli sociali da rispettare, attese, e così via. Ogni contenuto fornisce un tassello da aggiungere alla costruzione identitaria.
“Raccontare la propria storia non è solo un modo per differenziarsi e coinvolgere
in maniera diretta i propri interlocutori. È un modo per creare dei punti
di aggancio, delle ancore memorabili ed evocative capaci spesso di
suscitare empatia”. (Centenaro & Sorchiotti, 2013, p.117)
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- Bazarova, N. N., & Choi, Y.H. (2014). Self-Disclosure in Social Media: Extending the Functional Approach to Disclosure Motivations and Characteristics on Social Network Sites. Journal of Communication. Journal of Communication 64 (2014) 635–657.
- Centanaro, L., & Sorchiotti, T. (2013). Personal branding. Promuovere se stessi online per creare nuove opportunità. Milano: Hoepli.
- Goffman, E. (1969) La vita quotidiana come rappresentazione (trad. M.Ciacci) Bologna: Il Mulino. (Opera originale pubblicata nel 1959).
- Karaduman, I. (2013) The effect of social media on personal branding efforts of top level executives. Procedia - Social and Behavioral Sciences 99 (2013) 465 – 473.
- Labrecque, L.I., Markos, E., & Milne, G.R. (2010). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing 25 (2011) 37 – 50.
- Prunesti, A., & Perciavalle, M. (2013) Farsi assumere in tempo di crisi. Come sviluppare personal branding e relazioni online con i social media.
Milano: Franco Angeli
- Reynolds, M. (2011) Personal Branding with Social Media. Micheal Reynolds, eBookIt.com
- Tran, T. (2017). Designing a purposeful psoernal brand from zero to infinity, TEDxBerkeley. Disponibile in: https://www.youtube.com/watch?v=Alqt7pIbp_o
- Utz, S. (2015). The function of self-disclosure on social network sites: Not only intimate, but also positive and entertaining self-disclosures increase the feeling of connection. Computers in Human Behavior, 45, 1-10.
- Vittadini, N. (2018). Social Media Studies. I social media alla soglia della maturità: storia, teorie, temi. Milano: FrancoAngeli.
- Yang, L., & Tan, B. C.Y. (2012). Self-disclosure on online social networks: motives, context feature, and media, in Thirty Third International Conference on Information Systems, Orlando 2012.








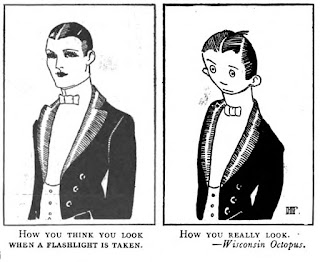

Commenti
Posta un commento