Articolo di Beatrice Marino
Se è vero che l’uomo, per i propri limiti biologici, tende a dimenticare, è altrettanto vero che per superare questi limiti ha creato nel tempo strumenti che gli rendessero più facile il ricordo. Strumenti che, però, «fino a qualche decennio fa non hanno influito sul rapporto tra ricordo e oblio: il primo era l’eccezione, il secondo la norma. Nell’era digitale questo equilibrio si è modificato radicalmente» (Mayer-Schönberger, 2016, p.81).
Ad oggi, i due poli sembrano essersi invertiti.
«Potremmo festeggiare l’evento. Dopotutto, non abbiamo cercato per millenni di liberarci dalla camicia di forza biologica dell’oblio e dalle carenze della memoria umana?» (Mayer-Schönberger, 2016, p.81). La domanda è utile a introdurre uno degli aspetti più controversi dell’uso dei social, e di Internet in generale: il trattamento della privacy e il controllo che possediamo sui dati che immettiamo in questo enorme magazzino digitale.
Alle radici del problema
Sembra, in particolare, che «l’implacabile memoria collettiva di Internet, dove l’accumularsi d’ogni nostra traccia ci rende prigionieri d’un passato destinato a non passare mai […] [imponga] un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone che possono facilmente conoscere informazioni sugli altri» (Rodotà, 2014, p.41).
Scaturisce, in questo contesto, la necessità di una tutela maggiore dell’individuo. Una tutela nei confronti di quegli stessi intermediari che possiedono i suoi dati, che lo schedano, lo profilano. Una tutela che si è tentato di attuare attraverso il nuovo regolamento (UE) n. 2016/679, anche noto come General Data Protection Regulation (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018. In particolare è l’art. 17 a disciplinare il cosiddetto diritto all’oblio, «inteso come diritto dell’interessato di ottenere la rimozione dalla pubblica circolazione di informazioni personali che lo riguardano, ove la loro rilevanza pubblica sia venuta meno per il trascorrere del tempo o per altri motivi» (Zanichelli, 2016, p.10).
La questione è articolata.
Questo diritto va bilanciato con altri, con cui si incrocia e con cui rischia di entrare in collisione: il diritto di cronaca, il diritto alla libertà d’espressione e d’informazione. In particolare, il riferimento all’universo online è indirizzato a regolamentare la cancellazione dagli archivi online di ciò che, a distanza di anni (quindi in condizioni di inattualità della notizia e di non interesse pubblico), può essere considerato dannoso per il soggetto preso in questione. Prima dell’avvento del GDPR, il diritto all’oblio aveva avuto riconoscimento nell’ambito della sentenza C-131/12 del 2014, nel cosiddetto caso Google Spain. Ma cosa era accaduto?
L’antefatto e il motivo dello scontro
Alla fine degli anni ’90, un cittadino spagnolo, Mario Costeja Gonzales, aveva subito il pignoramento di una casa di sua proprietà a seguito di un procedimento per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Nei primi mesi del 1998, un quotidiano a diffusione nazionale aveva pubblicato due annunci relativi alla vendita all'asta dell'immobile, dove appariva il nome dell'ex-proprietario nonché il fatto che la vendita fosse connessa a un pignoramento. Quindici anni dopo, nel 2013, Costeja Gonzales lamentava il fatto che, digitando il proprio nome sui motori di ricerca, apparissero ancora queste notizie, da lui considerate dannose per la propria immagine e per ricostruirsi una vita.
Si mosse dunque su due fronti paralleli: da un lato, chiese che il quotidiano in questione rimuovesse il contenuto; dall’altro lato, volle che Google eliminasse il link alle notizie. Il Garante spagnolo rifiutò il ricorso contro il quotidiano, ma acconsentì a quello contro Google.
Un caso eccezionale di vittoria sulla “memoria digitale”
La decisione finale spettò alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che riconobbe Google come effettivo responsabile di un trattamento dei dati, che doveva di conseguenza rispettare i termini dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e delle direttive europee in materia. Così Google Inc. (proprietaria del motore di ricerca) venne condannata a cancellare i link e, in generale, a eliminare su richiesta dei cittadini europei le indicizzazioni che li riguardassero, nel momento in cui non sussistevano ragioni particolari per la loro sopravvivenza, come il ruolo pubblico del soggetto. Nel caso di Costeja Gonzales, «i diritti fondamentali prevalgono, sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, e sull’interesse pubblico ad accedere all’informazione suddetta» (Scannicchio, 2014, p.1325). In realtà, però, il diritto all’oblio non riesce sempre ad essere uno strumento efficace: infatti le notizie e i dati si diffondono e diventano virali in pochi istanti e ottenerne la cancellazione non solo non è scontato, ma a volte non è neanche sufficiente a sistemare le cose.
Quanto siamo disposti a perdere?
Se, come scrive Rodotà (2014), la rete si configura oggi come «implacabile memoria collettiva» (p. 81), viene spontaneo chiedersi quanta libertà resti al singolo e, al contempo, quanta gliene venga sottratta una volta accettato l’accordo preliminare all’uso dei social network sites. E Internet, in questo gioco di do ut des, non sembra disposto a concedere molto.
Nonostante queste problematiche, pochi sarebbero disposti a rinunciare alle opportunità offerte dalla rete. «Accetterebbero l’astinenza digitale solo se la condivisione delle informazioni li esponesse a una minaccia reale notevole. […] È arduo convincere qualcuno a rinunciare a un vantaggio concreto presente per evitare un potenziale danno futuro» (Mayer-Schönberger, 2016, p.115).
Questo fa sì che si generi qualche cortocircuito. Soprattutto in quei casi in cui ciò che era stato condiviso online ha creato delle ripercussioni nella vita offline. Perché l’oblio, quell’oblio che gli antichi avevano ben conosciuto attraverso lo strumento della damnatio memoriae, oggi fatica a trovare spazio e anzi «oggi la vera damnatio, per le persone è ormai rappresentata dalla conservazione, non dalla distruzione della memoria» (Rodotà, 2014, p. 42).
Quando il ricordo diventa un problema
In effetti, di questa impossibilità di dimenticare si è resa bene conto Stacy Snyder. Questa donna, nell’aprile 2006, aveva completato il tirocinio per poter realizzare il suo sogno: insegnare. Tuttavia, qualcosa andò storto. «Venne convocata dai funzionari dell’università che le dissero che non avrebbe potuto insegnare. (…) Le venne negata l’abilitazione perché - così le dissero - il suo comportamento non si addiceva a quello di un’insegnante» (Mayer-Schönberger, 2016, p.1). Il problema, in particolare, scaturiva dal fatto che Stacy avesse condiviso sulla propria pagina Myspace una foto fatta ad una festa, in cui stava bevendo da un bicchiere, con un cappello da pirata in testa, nella cui didascalia, postandola, aveva scritto «A Drunken Pirate». L’università, avuta denuncia di ciò, ritenne la foto poco professionale e il tentativo di Stacy di cancellarla si rivelò inutile. Provò anche a far causa all’università, ma, nel dicembre 2008, la perse. Secondo la Federal District Court for Eastern Pennsylvania che si occupava del caso, la foto e la didascalia non erano protette dal Primo Emendamento, e non era possibile dunque intervenire.
Solo un caso isolato?
Quello di Stacy, in realtà, è un caso fra molti. Un caso senz’altro indicativo di quanto ciò che condividiamo possa condizionare la nostra vita e quanto sia difficile cancellare qualcosa, far sì che Internet dimentichi.
Non è andata diversamente, d’altronde, per un’altra ragazza, Kimberely Swann. Il datore di lavoro, infatti, decise di licenziare la giovane dopo aver scoperto che aveva postato su Facebook, a più riprese, lamentele su quanto fosse noioso il proprio impiego. Un altro caso, questo, che ci spinge a pensare che allora, ad oggi, «casi come quello di Stacy Snyder diventano paradigmatici non solo per una generazione, ma per tutta la società nel suo complesso» (Mayer-Schönberger, 2016, p.3).
Non si parla più solo di ingenuità nell’uso della rete, dei social; il problema è più profondo. Se ci troviamo all’interno di un contesto in cui le nostre informazioni, i nostri post, tutto ciò che ci rappresenta all’interno dei social network e della rete non ci appartiene più, si pongono degli interrogativi. Uno fra questi è posto bene da Mayer-Schönberger (2016): «se temiamo che qualsiasi informazione su di noi ci possa sopravvivere, siamo ancora disposti a esprimere liberamente la nostra opinione su pettegolezzi di poco conto, a condividere esperienze personali, a commentare fatti politici - o preferiamo autocensurarci?» (p.4).
Come tentare a risolvere il problema?
Non è facile trovare risposta: predicare un’astensione dall’uso dei nuovi strumenti digitali non sembra utile né realistico. Il richiamo ad una maggiore cautela da parte degli utenti potrebbe essere una strada percorribile, ma il gioco, il potere, è soprattutto nelle mani dei grandi players. Che hanno tutto l’interesse a mantenere i propri privilegi, a lavarsi le mani di fronte alle responsabilità. Lo dimostra lo stesso caso Google Spain, all’interno del quale in un primo momento il motore di ricerca cercò di tirarsi fuori dalla questione, asserendo di non dover sottostare alle normative europee, in quanto azienda di proprietà americana.
Non abbiamo in mano la sorte di ciò che postiamo
All’interno dei social network, poi, noi stessi agiamo con disinvoltura, dimenticando di trovarci in ambienti in cui lasciamo orme su orme, in cui la memoria domina sull’oblio. Dimentichiamo (noi sì, per assurdo, ancora dimentichiamo) di aver creato un meccanismo, degli strumenti, che oltrepassano quei nostri limiti biologici citati all’inizio. Degli strumenti che sul piatto della bilancia hanno assunto più peso degli users (o losers?) da cui traggono profitto. Hanno saputo trasformare la loro immensa memoria, la cancellazione dell’oblio in un’arma.
Un’arma che sono proprio loro, i grandi players del digitale, a tenere dalla parte del manico.






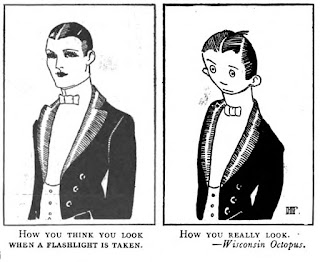

Commenti
Posta un commento